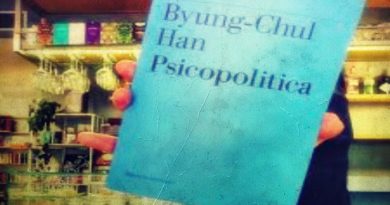Lotto 285 – capitolo ventesimo
 “Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.”
“Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.”
- K. Chesterton
Era già l’alba di un nuovo giorno quando ci recammo a restituire le biciclette al legittimo proprietario, che ci aspettava ansioso sull’uscio della bottega. Quegli utili mezzi di fortuna erano così in buono stato, così come le ceste di vimini nelle quali avevano trasportato pesi considerevoli, che il panettiere ci ringraziò calorosamente per l’attenzione e la cura che avevamo avuto nell’utilizzare quei veicoli. Era un tipo grosso, con un bianco camice impiastrato di farina ed un berretto, anch’esso bianco, che lo faceva sembrare più un infermiere che un bottegaio. Aveva degli occhi vispi che curiosavano su ogni cosa, dal nostro vestire alle ruote delle biciclette, dal rigonfiamento della mia giacca all’altezza dell’omero, alla cartella che l’aviere aveva portato con sé, nonostante la difficile impresa. La sua curiosità venne ben presto palesata quando ci chiese quale fosse stato il motivo che ci aveva spinto a chiedergli in prestito le biciclette, e proprio quelle, che avevano sul retro ceste molto capienti. Dicemmo, mentendo, che ci erano servite per trasportare medicinali destinati ai feriti nei primi scontri col nemico e che ora giacevano doloranti nel vicino Policlinico, rivelando, però, in quello stesso momento, la nostra possibile appartenenza alle bande armate che si stavano posizionando nel centro della città. Il panettiere capì e, senza altro indugio, ci condusse in un luogo sotterraneo, proprio sotto la bottega, cui si accedeva da una botola mimetizzata dalle macchine che stavano lavorando il pane. Anzi, per maggiore sicurezza, ci fornì di panini appena sfornati e di acqua fresca per rifocillarci. Il nascondiglio doveva essere stato già utilizzato perché, sul pavimento notammo resti di cibo e ciotole vuote. In più l’ambiente era stranamente riscaldato dal calore dei forni che penetrava tra le fessure, tanto che potemmo distenderci su dei sacchi di farina e riprendere il nostro sonno, se mai c’era stato. Ci risvegliò un trepestio di passi sopra le nostre teste ed urla di comando in una lingua che assomigliava al tedesco, ma che era più melodiosa, più scorrevole di questa. Sembrava uscisse da bocche aduse a parlare al contrario. Poi capimmo che era italiano, pronunciato però con le erre molto arrotate ed intercalato con frasi nell’altra lingua, che erano certo le più minacciose. Un parlare a noi quasi incomprensibile, vista anche la distanza e lo spessore delle mura che separavano le nostre orecchie dai suoni esterni. Sentimmo però, più distinto, un caricare di armi ed un incedere con passo pesante dei militari (perché di quelli quasi certamente si trattava) all’interno della panetteria. Erano certamente alla caccia di partigiani nascosti o di armi occultate. Con nostro disappunto ci rendemmo conto che le nostre armi erano rimaste nel cimitero, tranne la mia pistola, che aveva poche munizioni e non era certo una valida difesa contro fucili e mitra degli avversari. Così ci acquattammo nel fondo della cantina, sperando che la botola fosse ben celata alle indagini del nemico. Così fu perché dopo un po’ le grida scemarono ed i passi si sentirono allontanarsi dalla bottega.
Quando fummo sicuri che l’incursione dei soldati era finita potemmo mettere il capo fuori dalla botola che nel frattempo il padrone aveva riaperto. Notammo che i forni erano spenti, anche se ancora emettevano un leggero calore. Ne chiesi il motivo al panettiere ed egli mi disse, sconfortato, che il soldati non erano venuti per qualche retata, ma per razziare nel negozio e nelle vetrine il pane, e se ne erano andati con le tasche e gli zaini pieni, ridacchiando soddisfatti. Due di loro avevano addirittura requisito le due biciclette che erano appoggiate vicino l’ingresso, caricandole anch’esse di pane e sacchi di farina. Era la prima volta che avevo a che fare, anche se indirettamente, coi nemici ed ebbi un moto di rabbia per non essere potuto intervenire ma anche il conforto nel sapere che non erano stati fatti né violenza né prigionieri. Il negozio era quasi vuoto ma i lavoranti ed il padrone erano rimasti, grazie a Dio, incolumi.
Dopo quella esperienza mi venne da pensare che eravamo arrivati a fine ottobre e non avevo ancora rivisto i miei compagni. Che cosa avrei raccontato loro, che la mia missione era fallita, che ero ritornato indietro e poi mi ero perso nella campagna, o che tutto era stato un’illusione; che il vecchio che mi aveva ospitato era stato un fantasma e la mutilazione del ragazzo una terribile visione di guerra? Poi mi chiesi se la mia vera vita reale non fosse ripresa dal momento che avevo conosciuto l’aviere, il capitano in lutto per il figlio, l’ufficiale dei carabinieri sbandato ed i treni e il tram azzurro che mi aveva portato alla meta agognata, forse inventata anch’essa dalla mia fantasia, e la caserma, le armi e le biciclette del panettiere, la cantina dove avevamo trovato rifugio, e se la vita non fosse davvero un sogno, ma un sogno in cui il sognatore sa di sognare? E il Lotto 285, finora introvabile, sarebbe stata l’ultima tappa di un destino che si sarebbe dovuto compiere?
Questi ed altri pensieri mi avevano invaso la mente quando mi accorsi di stare camminando, assieme al mio fedele compagno, senza avere una meta precisa, come una pattuglia allo sbando, ma presto ci sapemmo orientare, e ci dirigemmo verso il centro della città, dove sapevo esserci un rifugio sicuro dove avrei trovato quasi certamente alcuni dei miei compagni, e, soprattutto, la mia giovane ragazza, che mi stava aspettando ansiosamente.
Era una cantina o, meglio, una carbonaia in un antico palazzo vicino ad un imponente monumento circolare che occupava una vasta zona disseminata di rovine, certamente di epoca romana. Da quest’ultimo si dipartiva un lungo viale, di recente costruzione, al cui inizio, su di un’alta parete, facevano spicco quattro tavole di marmo rappresentanti le conquiste dell’antica Roma, e lungo il cammino era fiancheggiato da statue di famosi imperatori. Sapevo bene che quel viale era stato aperto ed adornato per espresso volere del regime a simbolo della civiltà imperiale cui esso si ispirava. Sapevo anche che l’apertura di quel viale aveva comportato lo sventramento di una vasta zona e l’abbattimento di molte storiche case del centro. Interi quartieri erano stati sventrati da mani vandaliche ed i loro abitanti costretti ad emigrare verso lontane e sperdute borgate di periferia.
In una strada leggermente in salita, costeggiata da una parte da un parco attraversato da una linea tranviaria e dall’altra da eleganti palazzi signorili, individuammo l’ingresso della palazzina nella cui cantina si erano nascosti i miei amici cospiratori. Prima di scendere nel sottoscala ci guardammo intorno per assicurarci di non essere stati seguiti, precauzione che fino ad allora non avevamo adottato perché protetti dall’oscurità e dall’anonimato del nostro vestire. L’ambiente nel quale ci trovammo era al buio e consisteva in uno stretto corridoio, alla fine del quale, nell’oscurità, si faceva fatica a notare un’unica porta chiusa. Bussai con dei colpi ritmati secondo un codice che ci eravamo dati nelle prime riunioni e subito, attraverso uno spioncino, intravidi la faccia di uno dei miei compagni illuminata dalla fioca luce di una candela.
(continua)
di Maurizio Chiararia